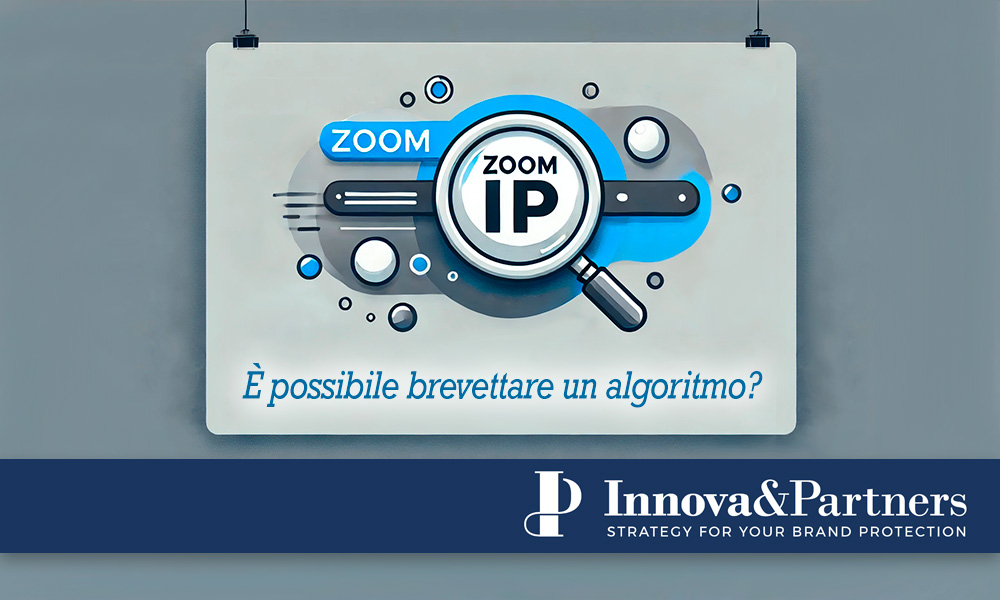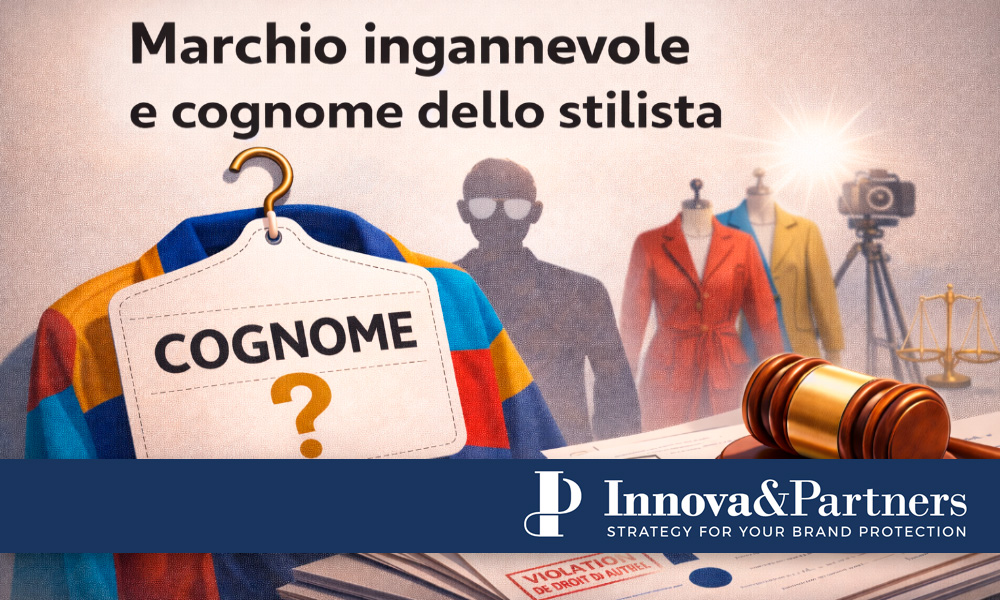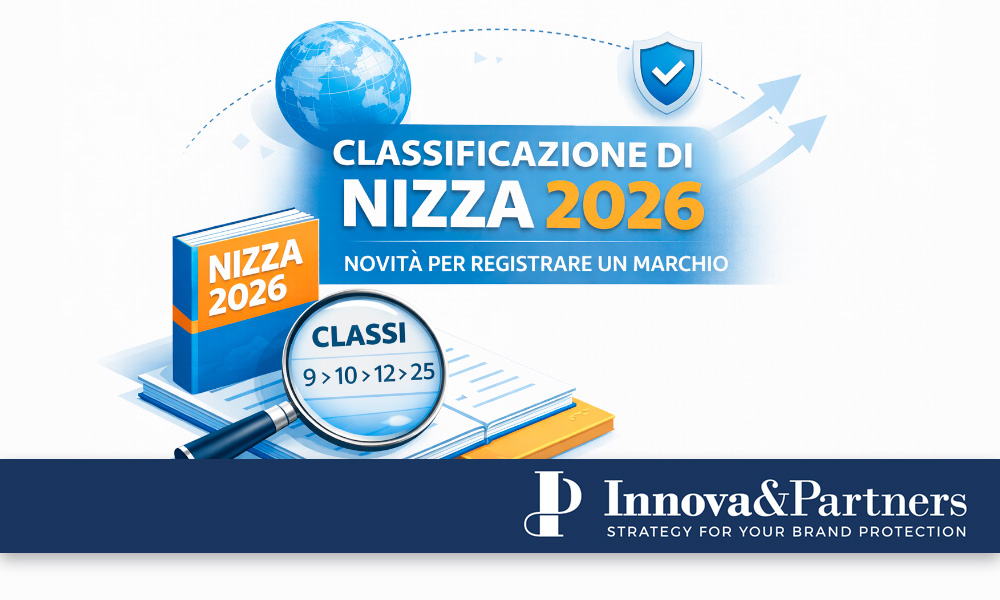omnisearch_title
Milano, officina del nuovo: invenzioni, brevetti e inventori milanesi – seconda parte

Abbiamo lasciato Milano (qui la prima parte dell’articolo) mentre accendeva le sue prime lampadine e ascoltava, stupita, la voce che viaggiava lungo i fili. Ma il Novecento è appena cominciato e la città non ha alcuna intenzione di rallentare. Anzi.
In questa seconda parte del viaggio esploreremo la Milano che progetta treni, che lavora sulla gomma, che scopre nuove materie e inventa il modo di vivere. Racconteremo l’avventura dei designer, dei fratelli Castiglioni e di Bruno Munari, l’ascesa del Salone del Mobile, l’impegno dei mecenati industriali e l’attualità delle startup. Perché l’innovazione a Milano non è un ricordo: è un mestiere, è un metodo, è un sistema vivo. E continua a funzionare silenziosa ed efficace come le grandi idee, che sembrano semplici solo quando sono già riuscite.
L'amarezza del genio: la storia di Giovanni Battista Piatti
Non tutte le storie di inventori milanesi hanno il lieto fine di Colombo o Pirelli che abbiamo raccontato nella prima parte dell’articolo. Per scoprirlo facciamo un salto al febbraio 1853, trent'anni prima della centrale elettrica costruita nei pressi del Duomo: l'ingegnere Giovanni Battista Piatti presenta al governo sabaudo una memoria sull’uso dell’aria compressa, utile sia ad azionare perforatrici multiple, sia a ventilare il cantiere del traforo del Frejus. La sua macchina ridurrebbe drasticamente i tempi dell’opera dai quarant'anni previsti a soli tredici.
Nel documento, Piatti non promette un miracolo: descrive circuiti d’aria, organi di manovra, turni di lavoro e manutenzione. La novità è proprio questa: trasformare un colpo di piccone in una sequenza meccanica ripetibile con la stessa aria a dare forza alle perforatrici e respiro agli operai.
La commissione chiamata ad esaminare la proposta si esprime negativamente, ma due commissari, Sebastiano Grandis e Germain Sommeiller, ne intuiscono il valore. Nei mesi successivi questi sviluppano e brevettano un sistema di perforatrici ad aria compressa per il cantiere del Frejus. Da qui nasce una lunga disputa di priorità tra Piatti e il gruppo Sommeiller-Grandis che segnerà gli anni successivi: Piatti infatti rivendica pubblicamente il proprio contributo in una serie di articoli.
È qui che la vicenda si fa cittadina: a Milano circolano ritagli e memorie in cui Piatti ricostruisce la propria proposta del 1853 e contesta l’adozione, anni dopo, di soluzioni che egli ritiene anticipate nelle sue carte. La polemica non riguarda lo “spirito dell’idea”, ma l’anteriore descrizione tecnica: disegni, dimensioni, modalità di alimentazione e di scarico dell’aria.
Diverse ricostruzioni storiche ricordano come Piatti, tra il 1857 e il 1866, torni più volte pubblicamente sull’argomento.
Nel tempo la polemica si inasprisce e non approda ad una conciliazione malgrado l’apertura del ministro Quintino Sella a un possibile riconoscimento.
Giovanni Battista Piatti muore nel 1867, a 54 anni, in via San Damiano a Milano.
Intanto il cantiere corre: la perforazione procede con l’aria compressa e l’organizzazione industriale che ne consegue. Quando Piatti scompare, la sua figura resta legata a quell’opera e alla discussione su cosa significhi dimostrare per primo una soluzione e vederla applicata da altri.
Solo nel 1894, grazie all'architetto Luca Beltrami che tiene una conferenza alla Scala per sostenere Piatti, Milano gli dedica un monumento postumo in Largo La Foppa. L'epigrafe recita: "Al benemerito dell'ardua impresa cui la sorte negò in vita onori e compensi."
È una lezione che la città non dimenticherà: non basta inventare, bisogna proteggere le proprie idee. Da allora Milano sviluppa una cultura del brevetto che diventa essenziale per il suo primato industriale.
 |
|
Monumento a Giovanni Battista Piatti in Largo La Foppa a Milano, opera dello scultore Salvatore Pisani (1859-1920) |
Il Novecento: dalla gomma alla plastica, il secolo dei materiali
Il Novecento milanese non comincia con uno slogan ma con un banco di prova: portare l’invenzione fuori dall’officina e farne industria. Qui «materiale» non è una parola neutra: è potere di forma, resistenza, affidabilità, brevetto. Il nuovo secolo si apre con le invenzioni di Pirelli che maturano: nel 1897 lo pneumatico per biciclette, nel 1899 quello per automobili. Sembrano innovazioni incrementali ma sono rivoluzioni: la mobilità su gomma cambia la geografia del mondo e Milano ne detiene i brevetti fondamentali.
Quegli pneumatici nascono dentro un sistema produttivo che Milano ha già avviato con la gomma: mescole, tele, stampi, logistica. L’ingresso negli pneumatici per biciclette alla fine dell’Ottocento, e poi in quelli per automobili, apre una catena di forniture locali e specializzazioni che alimentano officine e scuole tecniche; è anche il primo indizio di una verità semplice: cambia il materiale, cambiano gli utilizzi.
Ma la vera rivoluzione del Novecento milanese ha un nome meno noto: Giulio Natta. Professore al Politecnico dal 1936, Natta lavora sui catalizzatori. A partire dai risultati di Karl Ziegler sui nuovi sistemi catalitici, nel 1954 il suo gruppo ottiene per la prima volta polipropilene isotattico e ne chiarisce la struttura: in parole semplici rende possibile la plastica moderna, lavorabile su grandi volumi dalle pellicole alle fibre, dai casalinghi ai componenti tecnici.
Nel 1963 riceve il Nobel per la Chimica insieme a Ziegler: è il riconoscimento a una rivoluzione silenziosa ma pervasiva nata nei laboratori di Milano.
Dal 1957 il polipropilene isotattico entra in produzione industriale con Montecatini che avvia le linee in Italia: una filiera che da Milano irradia tecnologie, brevetti e applicazioni.
In pochi anni il materiale entra nei cataloghi delle aziende di tutto il mondo sviluppato: progettisti e tecnici hanno ora in mano un materiale nuovo con cui riscrivere prodotti e processi.
La storia di Natta si intreccia con quella della Milano del dopoguerra che si reinventa ancora una volta: infatti il 1° novembre 1964 Milano inaugura la sua prima linea metropolitana, la M1 Sesto Marelli–Lotto, e avvia un nuovo stile di comunicazione dell’innovazione con architetture pulite e percorsi leggibili: la grafica segnaletica di Bob Noorda e i layout rossi di Albini/Helg diventano un manuale d’uso della città.
Mobilità, materiali e progetto finiscono sullo stesso tavolo: è lo scenario da cui, pochi anni dopo, prenderà corpo la stagione del design come metodo.
 |
|
Bancone del laboratorio di Giulio Natta, esposto al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano |
Il design: l'invenzione della bellezza funzionale
Parallelamente all'industria pesante, Milano inventa qualcosa di più sottile ma non meno rivoluzionario: il design come metodo di pensiero. Non si tratta solo di rendere belli gli oggetti ma di ripensarli dalle fondamenta. Nascono redazioni, archivi, scuole e vetrine pubbliche che danno voce a una comunità di progettisti e imprese. È in questo ecosistema che si muove Gio Ponti, capace di tenere insieme pratica, critica e promozione culturale.
Ponti non costruisce soltanto edifici: mette in piedi strumenti che stabilizzano una lingua comune del progetto. Nel 1928 con la rivista Domus (la rivista che da Milano porta nel mondo architettura e design), crea un luogo dove l’industria incontra l’architettura e le arti applicate; con opere come il Grattacielo Pirelli (con Pier Luigi Nervi, cantiere 1956–58) dimostra che la modernità milanese può essere insieme tecnica, leggera e comunicativa.
Dove Ponti dà metodo e visione, i fratelli Castiglioni portano il colpo d’occhio che cambia l’uso degli oggetti. L’idea è semplice e radicale: mettere in corto circuito componenti quotidiani e funzioni nuove perché la tecnica diventi immediatamente comprensibile. Esempi diventati lessico comune: la Arco (1962) per Flos, un “lampione domestico” che libera la tavola da ingombri e gli esercizi di scomposizione come Mezzadro (1957) o Sella, i quali trasformano un sedile agricolo e una sella da ciclismo in sgabelli di design.
Non sono provocazioni: sono istruzioni d’uso sul rapporto tra parti industriali, comfort e spazio domestico.
Su questo terreno entra Bruno Munari, che si definiva "artista e designer", il quale aggiunge al rigore un’inedita pedagogia del progetto: un oggetto può insegnare come è fatto mentre lo si usa.
Tra manuali e sperimentazioni (basti pensare alla sua riflessione sul “fare per capire”), Munari mostra che la semplicità è una conquista: smontare, semplificare, rendere leggibile il processo. È la stessa attitudine che poi entrerà nelle mostre, nelle scuole per bambini e nei laboratori con le aziende, alimentando una cultura del prototipo accessibile e replicabile.
A Milano questa energia non resta negli studi ma diventa calendario urbano: da un lato la Triennale, che dal 1933 trova casa nel Palazzo dell’Arte e orchestra il confronto internazionale su architettura e arti applicate; dall’altro il Salone del Mobile, nato nel 1961, che ogni primavera riunisce imprese, designer e scuole. È la macchina civile che fa circolare velocemente prototipi, linguaggi e committenze diventando, in pochi anni, l’appuntamento più atteso del mondo del mobile e del design.
 |
|
Salone del Mobile 1969, veduta interna con stand |
I mecenati dell'innovazione: il cuore sociale del genio milanese
Ma c'è un elemento che attraversa tutte queste storie e che spiega perché proprio Milano sia diventata la capitale dell'innovazione italiana: il mecenatismo industriale. Non si tratta solo di filantropia ma di una visione in cui l'impresa ha una responsabilità sociale.
A Milano questo principio ha preso corpo in gesti molto concreti: casse di mutuo soccorso nate accanto alle officine, cooperative di consumo, scuole e biblioteche interne alle fabbriche, quartieri pensati per tenere insieme lavoro e vita. Il fine non era l’elemosina, ma costruire una comunità competente e stabile attorno all’impresa: un welfare “di fabbrica” che in città matura già tra fine Ottocento e primo Novecento.
Dentro questa trama, i nomi che seguono non sono solo biografie illustri: sono snodi in cui investimenti privati diventano infrastrutture civiche — scuole, case, istituzioni culturali — e fanno da volano all’innovazione.
- Ambrogio Binda, partito dal nulla, diventa re dei bottoni e con i proventi costruisce un villaggio operaio per centinaia di dipendenti dotato di case, servizi, asilo e scuola.
- Carlo dell'Acqua erige case operaie e dormitori, sale d’allattamento per le lavoratrici e sostiene asili, ospedali e scuole professionali nel territorio.
- Enrico Mylius trasforma la sua villa in cenacolo d’intellettuali e fonda la Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, ancora oggi attiva, avviando corsi tecnici e premi per far crescere industria e mestieri.
Sono loro che creano l'ecosistema in cui l'innovazione può fiorire: scuole tecniche, biblioteche, laboratori.
Questo mecenatismo non rimane chiuso nei perimetri delle fabbriche; a Milano diventa anche istituzione: basti pensare alla Società Umanitaria, fondata nel 1893 grazie al lascito di Prospero Moisè Loria per “mettere i diseredati in condizione di rilevarsi da sé” con lavoro e istruzione; oppure al Palazzo dell’Arte, sede della Triennale, reso possibile dalla grande donazione della famiglia Bernocchi, dove impresa e cultura del progetto dialogano in modo permanente.
Questa tradizione continua nel Novecento con Adriano Olivetti (che, pur essendo di Ivrea, ha a Milano il suo mercato principale) e arriva fino ad oggi con la Fondazione Pirelli (cultura d’impresa, programmi educational e iniziative sull’innovazione), la Fondazione Bracco (scienza, cultura e impatto sociale, con attenzione a giovani e donne) e la Fondazione Cariplo (bandi per ricerca scientifica, insieme a arte/cultura, ambiente e sociale): un ecosistema che continua a finanziare ricerca e innovazione.
Innova&Partners – Milano, la casa delle idee
Con questa seconda parte conclusiva del nostro viaggio, abbiamo attraversato cinque secoli d’invenzioni, laboratori, intuizioni, prototipi e idee protette: da Leonardo alle startup, da Piatti ai mecenati, da una lampada di Munari al design thinking nelle imprese di oggi.
Questo percorso dimostra una cosa chiara: a Milano le idee non passano, restano. Si trasformano in metodo, in industria, in cultura.
Oggi Milano è un ecosistema di startup riconosciuto a livello europeo (circa metà del valore tech italiano si concentra qui) e il Politecnico guida il Paese per domande di brevetto. Nel distretto MIND convivono Human Technopole e il nuovo IRCCS Galeazzi, segno di una filiera life sciences in crescita.
È la città dove nascono unicorni tecnologici e dove quella miscela di design thinking e ingegneria permea ogni settore.
Raccontare le invenzioni nate a Milano e gli inventori milanesi ha un senso pieno se, oggi, chi inventa può contare su una casa delle idee: un luogo che ascolti, verifichi, progetti la tutela e la valorizzazione con la stessa cura con cui un tempo si disegnava una macchina o si tracciava una nuova linea di tram.
A Milano questa casa esiste e prende la forma di un moderno “studio marchi e brevetti” che lavora da vent’anni a fianco di imprese e progettisti, conosce la città e i suoi tempi, parla la lingua dei marchi, dei brevetti, dei modelli di utilità, del design, del know-how e dei nomi a dominio; costruisce ricerche di anteriorità, definisce strategie di deposito in Italia e in Europa, presidia la sorveglianza e difende i diritti quando serve (pareri di libera attuazione e interferenze); ma, soprattutto, si muove con tatto, perché la tutela – come il buon progetto – non si nota: funziona.
Questa è Innova&Partners – Milano: la sede locale di un grande network che unisce rigore tecnico e sensibilità imprenditoriale; consulenti che sanno parlare con l’ingegnere e con il designer, con lo startupper e con il general counsel; un ufficio che non impone schemi ma costruisce su misura; che affianca la grande impresa e la bottega, la scale-up globale e l’inventore solitario; che trasforma l’intuizione in percorso, dal primo confronto alla strategia di deposito, dalla registrazione alla gestione contrattuale, fino alla difesa dei diritti quando il mercato alza la voce.
Se stai lavorando ad un’invenzione, ad un prototipo, ad un nuovo marchio per la tua azienda o i tuoi prodotti, l’ufficio brevetti e marchi Innova&Partners è il tuo interlocutore naturale: discrezione, cura, protezione su misura.
Contattaci e raccontaci il progetto; insieme cercheremo la strada più breve e più sicura perché quell’idea resti tua e cresca bene.
 |
Data
28/10/2025Categoria
notiziaProteggi la tua innovazione!
Scopri come tutelare il tuo marchio, brevetto o proprietà intellettuale con il nostro supporto personalizzato.
Compila il form per maggiori informazioni.
Ultime news
Leggi tutte le newsZoom n.6: è possibile brevettare un algoritmo?
“ZOOM IP”: una rubrica d’approfondimento sulla Proprietà Intellettuale. Zoom n.6: è possibile brevettare un algoritmo? Sì, ma solo se l’algoritmo èLeggi tutto
Marchio ingannevole e cognome dello stilista
Quando l’uso di un nome famoso può ingannare sull’origine creativa dei capi d’abbigliamento Un marchio che coincide con un nome famoso puòLeggi tutto
Classificazione di Nizza 2026: novità per registrare un marchio
Dal 1° gennaio 2026 è in vigore la Classificazione di Nizza 2026 (13ª edizione). In questa guida spieghiamo le nuove classi di prodotti e servizi, iLeggi tutto