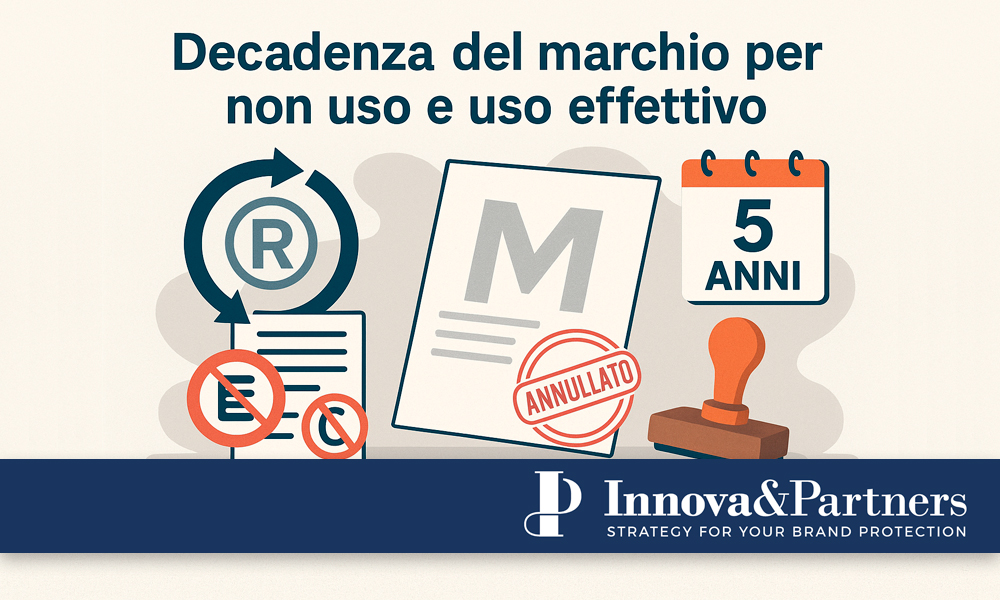omnisearch_title
Un prodotto venduto può invalidare il tuo brevetto

La disponibilità al pubblico è sufficiente a privare un’invenzione della novità: anche un prodotto in commercio con composizione ignota è considerato tecnica nota e può compromettere un brevetto.
Chi deposita un brevetto deve dimostrare che l’invenzione sia nuova e frutto di attività inventiva rispetto a ciò che già esiste, ossia lo stato della tecnica. L’articolo 54(2) della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) considera stato della tecnica tutto ciò che, prima della data di deposito, sia stato reso accessibile al pubblico.
Ma che implicazioni ha la vendita di un prodotto se al momento della sua commercializzazione nessuno era in grado di comprenderne la composizione o riprodurlo?
Anche in questo caso il prodotto è considerato parte dello stato della tecnica a partire dalla data in cui è stato reso disponibile al pubblico (ossia da quel momento la sua disponibilità diventa un fatto giuridico rilevante che priva l’invenzione della novità).
Proprio su questo interrogativo si è pronunciata l’Enlarged Board of Appeal dell’EPO (L’Ufficio europeo per i brevetti) con la decisione G 1/23 emessa il 2 luglio 2025. La vicenda specifica riguardava un materiale per celle solari (caso EP 2 626 911, opposizione T 0438/19), ma il principio sancito vale per qualsiasi settore tecnologico e interessa tutte le imprese che sviluppano prodotti complessi.
Il caso Borealis-Mitsui che ha portato alla G 1/23
Per capire l’importanza di questa decisione è utile ripercorrere brevemente il caso che l’ha originata.
Nel 2016 Borealis contestò il brevetto di Mitsui Chemicals (EP 2 626 911) circa un materiale sigillante per moduli fotovoltaici: Borealis sosteneva che il polimero sigillante Engage 8400, già venduto prima della data di deposito, anticipasse l’invenzione.
Le parti concordavano sul fatto che la composizione chimica e il processo produttivo dell’Engage 8400 non fossero pubblici, né facilmente determinabili da un tecnico medio. Mitsui sosteneva quindi che, non essendo possibile comprendere o riprodurre il prodotto all’epoca, non potesse considerarsi parte dello stato della tecnica.
In prima istanza l’opposizione fu respinta dall’EPO ma Borealis impugnò questa decisione davanti al Technical Board of Appeal, una delle commissioni tecniche indipendenti che giudicano i ricorsi contro le decisioni interne degli esaminatori o delle divisioni di opposizione dell’Ufficio.
Durante l’esame del ricorso (procedimento T 0438/19), la commissione ritenne che la questione giuridica sollevata fosse di particolare importanza e meritevole di un chiarimento uniforme per tutta la giurisprudenza europea. Per questo motivo trasmise la questione all’Enlarged Board of Appeal, il massimo organo giurisdizionale dell’EPO che ha il compito di assicurare uniformità e coerenza delle interpretazioni della CBE (Convenzione sul Brevetto Europeo).
Dopo aver esaminato la questione, l’Enlarged Board ha stabilito un principio semplice ma incisivo: un prodotto messo in commercio è parte dello stato della tecnica anche se la sua composizione o il suo processo produttivo non erano comprensibili o riproducibili al momento della messa in commercio.
Nel dettaglio, escludere tali prodotti dalla prior art, cioè l’arte nota, porterebbe a risultati giuridicamente insostenibili perché significherebbe ignorare materiali ampiamente disponibili sul mercato in maniera incoerente con la funzione del brevetto, la quale si fonda su ciò che il pubblico può effettivamente vedere e acquistare.
La “riproducibilità” va quindi intesa in senso ampio: non è necessario ricostruire la composizione, è sufficiente che il prodotto fosse acquistabile sul mercato e accessibile al tecnico del settore per considerarlo parte dello stato della tecnica.
Questa impostazione evita di cadere in una finzione giuridica secondo cui un prodotto, solo perché non completamente analizzabile o replicabile, sarebbe da considerarsi “invisibile” al diritto brevettuale. Per chiarire: il fatto che un prodotto sia già disponibile sul mercato, e quindi accessibile concretamente, è sufficiente per collocarlo all’interno dello stato della tecnica indipendentemente dalla possibilità di comprenderne tutti i dettagli tecnici al momento della sua diffusione.
Non riproducibilità e attività inventiva: concetti distinti
Un altro aspetto chiarito dalla decisione è la distinzione tra novità e attività inventiva.
La non riproducibilità di un prodotto non lo esclude dallo stato della tecnica: questo significa che un’invenzione identica ad un prodotto già in commercio non può essere considerata nuova.
Per valutare l’attività inventiva, la decisione sottolinea che non basta considerare la semplice scoperta del prodotto: occorre verificare quali informazioni un tecnico avrebbe potuto effettivamente ricavare dal prodotto stesso tramite analisi o documentazione, e se queste avrebbero potuto guidarlo in modo non ovvio verso la soluzione proposta. Va inoltre chiarito che, anche se la composizione interna di un prodotto non era comprensibile al momento della commercializzazione, ciò non impedisce che le sue caratteristiche tecniche possano essere provate in un secondo momento.
La decisione G 1/23 conferma che la qualificazione giuridica di un prodotto come parte dello stato della tecnica dipende dalla sua effettiva disponibilità al pubblico, non dalla completezza immediata delle informazioni tecniche: le proprietà del prodotto possono essere ricostruite o dimostrate in seguito tramite analisi, confronti, letteratura tecnica o altri mezzi di prova.
Esempi pratici
La decisione G 1/23 non è solo una regola astratta ma una realtà quotidiana per chi sviluppa prodotti complessi. Per comprendere appieno le implicazioni di questo principio è utile tradurlo in situazioni concrete: prendiamo ad esempio il caso di un’azienda metallurgica che sviluppi una lega innovativa e la immetta sul mercato. Anche se nessuno fosse in grado di analizzare la lega e comprenderne la composizione, il solo fatto di averla resa disponibile al pubblico la renderebbe parte dello stato della tecnica e impedirebbe la successiva brevettabilità.
Lo stesso meccanismo si applica, secondo un altro esempio, ad un produttore farmaceutico che volesse vendere un principio attivo mantenendone segreta la formula, o a un’impresa che proponesse polimeri avanzati dalle caratteristiche uniche: anche se la composizione interna di questi prodotti potrebbe essere difficile da determinare, la loro messa in commercio li renderebbe comunque disponibili al pubblico sotto il profilo giuridico e li includerebbe nello stato della tecnica indipendentemente da un eventuale ritiro successivo dal mercato.
Pur essendo nata da un caso in ambito chimico, la decisione G 1/23 ha quindi una portata ben più ampia e interessa ogni settore tecnologico in cui i prodotti risultano difficili da decifrare o replicare, in particolare in ambiti ad alta complessità come la farmacologia, i materiali compositi, i sistemi elettronici integrati e i software contenenti componenti “black box”. In tutti questi casi, la sola messa in commercio rende il prodotto rilevante ai fini brevettuali, anche quando i dettagli tecnici non siano pienamente accessibili. Il principio stabilito, quindi, non si limita a un contesto specifico, ma rappresenta un riferimento trasversale per la valutazione dello stato della tecnica.
Come pianificare la strategia brevettuale
Il principio stabilito da G 1/23 avvicina l’EPO all’approccio adottato negli Stati Uniti dove è considerato parte dello stato della tecnica qualsiasi prodotto messo in commercio prima della presentazione della domanda di brevetto, indipendentemente dalla possibilità di riprodurlo. A differenza degli Stati Uniti, però, in Europa non è previsto alcun periodo di tolleranza successivo alla vendita: la prima commercializzazione preclude definitivamente la brevettabilità.
La decisione ha suscitato ampio dibattito tra i professionisti della proprietà industriale: molti ritengono che una definizione più ampia di “stato della tecnica” renderà più difficile ottenere brevetti in settori complessi dove prodotti già venduti sono difficili da analizzare. Noi di Innova&Partners raccomandiamo alle imprese di monitorare attentamente lo stato della tecnica e di depositare le domande di brevetto senza ritardi, evitando di confidare esclusivamente sulla segretezza industriale. È dunque essenziale integrare la strategia brevettuale fin dalle prime fasi di sviluppo del prodotto e coordinarla attentamente con la strategia commerciale.
Data
07/08/2025Categoria
notiziaProteggi la tua innovazione!
Scopri come tutelare il tuo marchio, brevetto o proprietà intellettuale con il nostro supporto personalizzato.
Compila il form per maggiori informazioni.
Ultime news
Leggi tutte le newsDecadenza del marchio per non uso e uso effettivo
Cosa succede se un marchio registrato non viene utilizzato? Quando scatta la decadenza per non uso? Come dimostrare l’uso effettivo e affrontare laLeggi tutto
Zoom n.5: posso registrare un marchio creato con l’intelligenzaLeggi tutto
“ZOOM IP”: una rubrica d’approfondimento sulla Proprietà Intellettuale. Zoom n.5: posso registrare un marchio creato con l’intelligenzaLeggi tutto
Quando un filo giallo diventa identità: Dr. Martens protegge cucitureLeggi tutto
Cuciture, suole e scritte incise diventano marchi. La Corte d'appello di Bruxelles prende posizione su un caso emblematico di design iconico e tutelaLeggi tutto